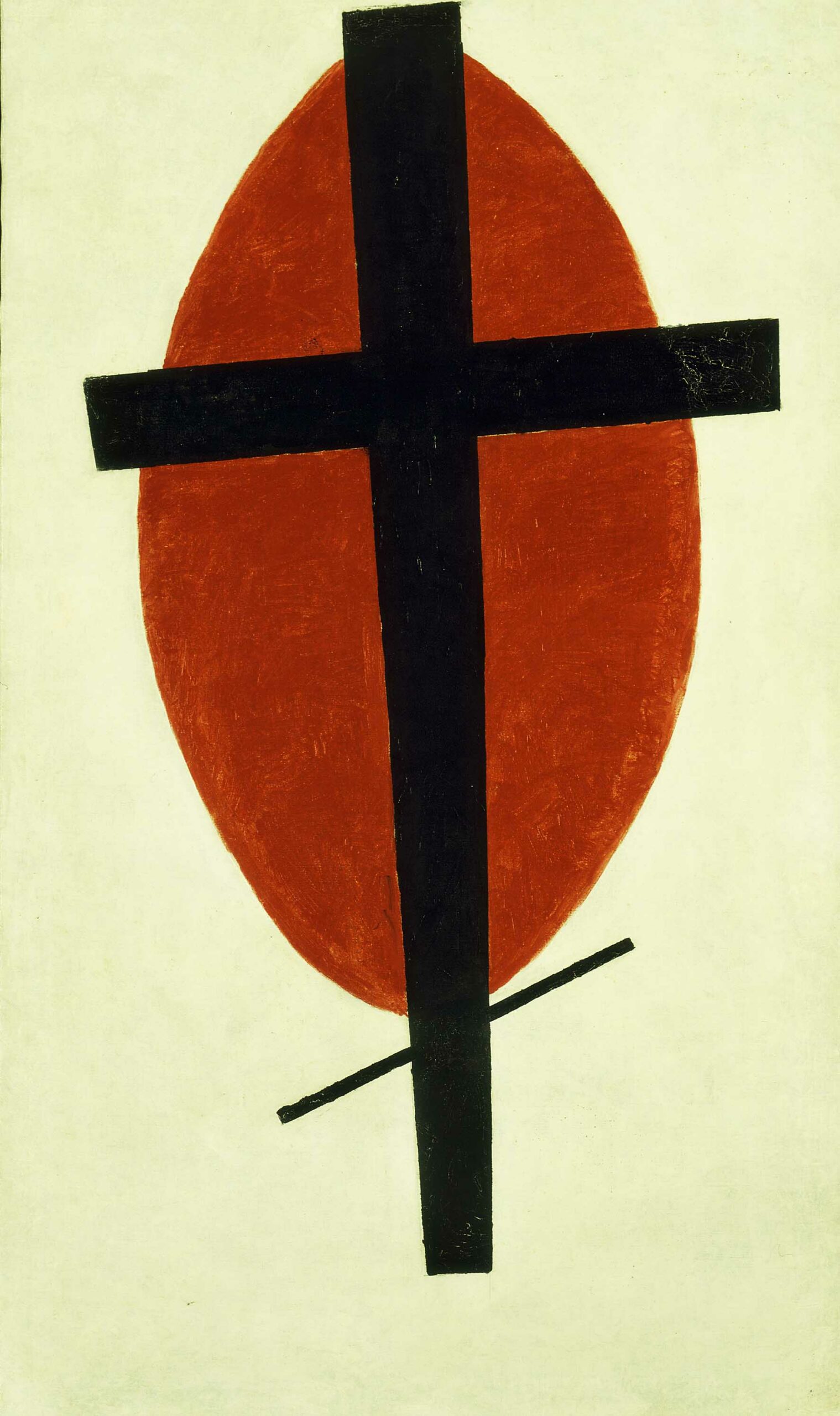Louis-Marie Chauvet
Il presente contributo vorrebbe essere un tentativo per dimostrare quanto sia importante per la teologia della liturgia in generale, e per la sacramentaria in particolare, considerare il sacramentum come espressione corporea di tipo simbolico. A tal fine si è scelto di focalizzare la riflessione sulla nozione di “spazio simbolico”. Con questa espressione intendiamo riferirci a quel particolare spazio o “sito” creato dall’architettura del luogo, dalla musica, dalla disposizione degli oggetti, come pure dai diversi attori nell’esercizio stesso delle funzioni che loro competono.
Lo spazio liturgico
In tal caso, per spazio non si intende semplicemente la materiale estensione di un’area. Si tratta, invece, di una costruzione di carattere culturale con forti implicanze psicologiche. Inoltre, lo spazio liturgico è un luogo “in-formato”, nel senso aristotelico e scolastico del termine, dalla tradizione e dalla memoria collettiva dei cristiani. Ora, è precisamente questa “forma” che fa della “materia” estesa uno spazio liturgico. Questa forma è ovviamente legata all’architettura del luogo. Ma essa è anche tributaria nei confronti delle diverse figure che vengono create dall’azione della celebrazione o, comunque, che ad essa rimandano (ed è ciò che qui ci interessa in modo prioritario). Troviamo, pertanto, in questo spazio degli elementi stabili costituiti da “pietre” materiali, la cui disposizione esprime la struttura stessa della chiesa costituita da “pietre viventi”: il battistero in fondo alla chiesa, come luogo in cui si effettua l’ingresso di ciascuno nella comunità cristiana; l’ambone e l’altare, al cuore stesso dell’edificio, esprimendo così il posto centrale della Parola e dell’eucaristia; la sede del presidente, che richiama la struttura ministeriale della chiesa, ecc. Altri elementi sono, invece, variabili: alcuni sono legati ai tempi liturgici (cero pasquale, decorazione floreale, musica e canti); altri ancora sono legati ai momenti della celebrazione (gesti, atteggiamenti e movimenti); altri poi sono legati alla natura e alla funzione dei diversi ministri e/o dell’assemblea. È tutto questo complesso di cose che insieme contribuisce concretamente a configurare lo spazio liturgico.
Questi molteplici elementi, siano essi stabili o mobili, non sono in grado però di esprimere pienamente il loro significato se non attraverso il rapporto che essi instaurano fra di loro. Si tratta in fondo di una legge fondamentale per ogni simbolo: «Non si può isolare un simbolo senza distruggerlo, senza farlo cadere nell’immaginario ineffabile» [1]. Ad esempio, se l’altare non è pensato nel contesto di tutto quanto lo spazio e degli oggetti fra i quali trova il suo posto, cioè al centro del coro, in relazione con l’ambone da dove è proclamata la Parola, la sede del presidente, la croce, e non è rivolto verso l’assemblea, esso potrebbe evocare qualsiasi cosa, o quasi, secondo l’immaginazione del momento. Ogni elemento viene così a “comporsi” con gli altri per formare figure diverse, che parlano simbolicamente ai partecipanti. E questa interazione che costituisce lo spazio liturgico. Pertanto, ogni singola celebrazione è l’occasione per dare a questo spazio una nuova “configurazione”. Con un’oscillazione che passa dalla metafora alla metonimia, secondo i diversi casi, gli oggetti, che di per sé sono muti, si mettono allora a parlare. Il che avviene metaforicamente, quando essi sollecitano ad entrare nel mistero di Cristo; metonimicamente, quando questi oggetti mettono in relazione l’assemblea presente con le passate generazioni, che le hanno trasmesso la tradizione viva della chiesa, e con tutte le altre comunità cristiane che nel loro insieme, attraverso la comunione di fede, formano l’unica chiesa di Cristo.
In tal modo possiamo dire che lo spazio liturgico costituisce così una specie di cristallizzazione quasi-“sacramentale” dell’intero sistema dei valori propri del cristianesimo. È tutta quanta la tradizione della chiesa che si produce, cioè simultaneamente si rende visibile come tradizione “trasmessa” (traditio tradita) e “tradente” (traditio sese tradens). Infatti, il “testo” della tradizione “trasmessa” citato dalla liturgia che, come sottolinea I. Renaud-Chamska, non è altro che un insieme di citazioni [2], non è semplicemente costituito da espressioni verbali o scritte, relegate unicamente all’ambito delle significazioni, ma – molto di più – da particolari “modalità” (l’éthos liturgico con le sue variazioni di stile, con il suo particolare tono di voce, con i suoi diversi modi di cantare, i suoi atteggiamenti, gesti e positure), come pure dalle diverse regole, funzioni e ruoli che costituiscono la chiesa. Lo spazio liturgico costituisce, dunque, uno dei luoghi fondamentali di “produzione” della tradizione – per questo esso è eminentemente iniziatico.
Uno spazio iniziatico
Come ogni iniziazione, anche l’iniziazione cristiana non arriva ad essere veramente efficace se essa non costituisce un processo globale che, a livello personale, deve senza dubbio rivolgersi all’intelletto, ma anche, se non di più, al cuore, alla memoria e al corpo. Un’iniziazione che, a livello collettivo, esige di essere in stato di osmosi costante con la grande chiesa, quella di ieri come quella di oggi, poiché è la chiesa che “trasmette” ciò che ha “ricevuto”. Sia ben chiaro, in una società “critica” e “pluralista” come la nostra non ci si può esimere in tale settore dalla comprensione intellettuale e dalla verifica critica. Con tutto’ ciò, sarebbe un errore se si intendesse, soprattutto oggi, l’iniziazione cristiana come il risultato di un itinerario “intellettuale”, dove alla fine tutto viene compreso. In questo genere di cose non si arriva a “comprendere” se non quando si è afferrati e coinvolti direttamente dal di dentro. Non esiste altro modo per poter entrare nel “mistero di Cristo” se non quello di lasciarsi afferrare da lui. Essere iniziati non significa affatto aver imparato delle “verità da credere”, ma aver “ricevuto” una tradizione attraverso tutti i pori della pelle, se così si può dire. L’iniziazione si effettua attraverso una pedagogia strettamente legata all’esperienza di vita: essa non si pone semplicemente al termine di un cammino intellettuale, per quanto oggi necessario, ma all’origine di una identità.
Ora, lo spazio liturgico, nel significato di cui sopra, funge da “matrice” dentro la quale il soggetto viene generato come cristiano. Questo spazio offre il lessico e la grammatica dell’identità cristiana, così come essi sono stati trasmessi dalla tradizione. Si può quindi parlare di un quasi visibile verbum, una parola quasi visibile, di un sacramentum in senso agostiniano del mistero cristiano. Soprattutto per le generazioni più giovani si tratta di uno spazio iniziatico dentro il quale ciascuno è invitato ad entrare, a prendere posto – quel posto “riservato” che lo attende in quanto battezzato – e a lasciarsi “prendere” affidandosi a quelle cose che, per la loro “composizione”, parlano la lingua cristiana e che diventano pertanto tramite di qualche cosa che appartiene alla “Parola di Dio”. Durante i secoli di “cristianità”, l’iniziazione si effettuava principalmente attraverso la lenta incubazione nel corpo, nella memoria e nel cuore di tutti e di ciascuno, di tutti quei punti di riferimento inculcati dalla liturgia e dal suo spazio sul ritmo delle domeniche e delle feste e che esprimevano l’identità cristiana. Oggi si commetterebbe un grave errore se si dimenticasse questa dimensione tenendo conto soltanto della ragione critica.
Un sito illocutorio
Come abbiamo già sottolineato, è in primo luogo attraverso la modalità simbolica della metafora e della metonimia che lo spazio liturgico parla ai partecipanti (o ai semplici visitatori). Ora, negli atti linguistici la dimensione simbolica è prioritariamente veicolata da ciò che J.L. Austin chiama l'”illocutorio”. Infatti, questo autore ha dimostrato che ogni atto di linguaggio comporta tre dimensioni [3]. La dimensione “locutoria” riguarda il contenuto o i significati di ciò che è enunciato, in quanto parlare significa sempre dire qualcosa su una realtà. Tuttavia, parlare è sempre rivolgersi a qualcuno: ad altri o a se stessi come ad un altro. Ciò che viene detto, cioè il “locutorio”, in quanto rivolto ad altri, ha su costoro degli effetti: sentimenti, idee, passaggio all’azione, ecc. Orbene questi effetti rivelano la dimensione “perlocutoria” degli atti linguistici, la quale designa dunque una realtà senza dubbio generata dal linguaggio, ma esterna a questo.
Esiste anche una terza dimensione che è pure legata al fatto che ci si rivolge a qualcuno, ma che è di ordine diverso dai semplici effetti perlocutori citati. L’ “illocutorio” designa, infatti, una realtà “intralinguistica” creata essa stessa dall’enunciazione. Per esempio, un enunciato del tipo “chiuda la porta” comporta una dimensione locutoria (informa che c’è una porta che deve essere chiusa), una dimensione perlocutoria (il destinatario ha piacere a rendere questo servizio, o al contrario si sente irritato perché altri hanno con negligenza lasciato la porta aperta; egli, quindi, va oppure no a chiudere la porta), e infine una dimensione illocutoria: il semplice enunciato, infatti, situa il locutore in un rapporto di superiorità gerarchica nei confronti del destinatario. Quindi un rapporto di posizione fra queste due persone, che nel caso è dissimmetrico, viene o creato o rafforzato. Non ha alcuna importanza qui giustificare o meno questo rapporto dal punto di vista etico. Alla nostra problematica è pertinente soltanto il legame tra superiore e subordinato creato (a torto o a ragione) dall’atto linguistico stesso. I verbi “performativi” (sempre usati al presente e alla prima persona singolare) agiscono in modo prioritario proprio su questo registro illocutorio: “Ti prometto di venire a trovarti domani”, “Io ti perdono”. Questi sono atti linguistici nel senso più forte del termine “atto”, in quanto producono realmente ciò che dicono, dando vita così ad un nuovo rapporto fra gli interlocutori; la loro situazione reciproca non è più uguale a quella di prima. Senza dubbio la parola può essere felice o infelice: dipende se mantengo la promessa o se continuo a cercare la vendetta. Ciò nonostante resta sempre il fatto che quell’atto linguistico mi ha dato modo di situarmi in modo diverso nei confronti del mio interlocutore; l’effetto è chiaramente intralinguistico.
Ora, ogni atto linguistico, sebbene con una variabilità di gradazioni, comporta queste tre dimensioni. All’opposto della frase “Io ti perdono”, dove la dominante è nettamente la dimensione illocutoria, un enunciato come “Questo inchiostro è nero” è quasi esclusivamente contrassegnata dalla dimensione locutoria. “Quasi”, perché qualcosa della dimensione illocutoria è pur sempre presente nella misura in cui l’enunciatore si pone implicitamente di fronte al suo interlocutore come ad un soggetto capace di ragionare: questa penna è certamente nera e per niente rossa! Da questi esempi semplicissimi si intuisce che assai sovente l’illocutorio viene comunicato più dalle modalità dell’enunciazione che nell’enunciato stesso. Il “modo”, cioè il tono di voce adottata, lo sguardo, la mimica, i gesti, come pure le esitazioni, le ripetizioni o i “vuoti” del discorso, è in questo caso di capitale importanza: è proprio nella modalità che assai sovente, al di qua dei discorsi stessi, si rende comprensibile la “parola”, cioè quello che pone in rilievo la “domanda” dell’altro. Orbene, è proprio questa domanda, che in definitiva è sempre una richiesta di riconoscimento e di amore, che permette al soggetto umano di diventare e intrattenersi come tale. Per questo motivo la dimensione illocutoria è costantemente all’opera nella comunicazione con gli altri.
Se lo spazio liturgico parla, e se lo fa principalmente con modalità simbolica, è per il fatto che esso costituisce un “sito illocutorio”. Nel mondo agricolo della Vandea, dove sono nato, quando delle persone vengono in visita alla fattoria, le si invita (almeno gli uomini) a venire in cantina per bere un bicchiere. In questo luogo fresco e immerso nell’oscurità vige un codice rituale di comportamento che vi identifica subito come del posto oppure no: il modo di salutare le persone presenti, di squadrarle, di stringere loro la mano, di appoggiarsi alle botti, di prendere il bicchiere di vino che viene offerto (un unico bicchiere che fa il giro di tutti), di bere e di versare a terra le ultime gocce, di unirvi alla conversazione, di conformarvi al tono di voce dell’ambiente, persino all’accento particolare della regione. Tutto questo insieme di cose, dove gli elementi, come in una chiesa, interagiscono componendosi gli uni con gli altri, crea uno spazio, cioè un sito illocutorio dove ciascuno viene in qualche modo situato dall’altro nella sua identità: come un contadino del luogo oppure come un “parigino”; come uno della regione (o addirittura dello stesso comune) oppure no; come uno che “si tiene su” o al contrario come “uno di noi”, ecc. Niente di tutto questo è presente nel contenuto “locutorio” della conversazione e, tuttavia, proprio tutto questo determina in gran parte il genere di conversazione e ciò che di questa conversazione viene “inteso” dagli uni e dagli altri. È precisamente questo uno degli aspetti maggiori del simbolo secondo P. Ricoeur [4]: esso non è tanto un “oggetto” da interpretare quanto piuttosto un “operatore immanente d’interpretazione”. L’insieme degli elementi che di per sé sono muti (la semioscurità, l’odore del vino, il fresco, la disposizione delle botti, ecc.) o quasi muti (il tono della voce, l’accento, i modi di comportarsi, ecc.), che fanno di quel particolare luogo una cantina della campagna vandeana, costituiscono in realtà l’operatore interno d’interpretazione di ciò che viene detto con parole, mimica o gesti. Il contenuto, come la ricezione, di ciò che viene detto è ampiamente “in-formato” (nel senso di cui si è detto prima) dal contesto, che costituisce il “sito illocutorio”. Cosicché, in un certo luogo, l’insieme parla ancor prima che si cominci ad aprire bocca… Ed è indispensabile intendere ciò che parla al di qua della conversazione, se si vuol cogliere in profondità ciò che viene detto esplicitamente. «L’uomo dunque parla, ma è perché il simbolo lo ha fatto uomo» [5].
Ora, tutto questo, mutatis mutandis, si può dire anche dello spazio liturgico. Ovviamente questo spazio è costituito da elementi visivi, sonori, tattili, ecc. che, in genere, hanno uno specifico significato cristiano. Ciò non toglie che anche questo spazio parla principalmente a livello della sua simbolica globale. E, anche in questo caso, l’insieme parla molto prima che qualcuno abbia aperto bocca. In quanto “operatore immanente d’interpretazione”, questo sito illocutorio determina in gran parte ciò che è espresso e ciò che viene “inteso”. Al di qua del contenuto teologico che lo stile architettonico di questa o quella chiesa comunica in modo tacito, è la forma stessa del messaggio trasmesso che qui è in gioco: il ministro che prende la parola assume (secondo la tradizione) un tono di voce conforme allo spazio sacro; il corpo formato dai fedeli si mantiene in una gravità che manifesta, potremmo dire a fior di pelle, la pregnanza del mistero da cui si sente avvolto; il giubilo dell’Alleluia o la supplica del Kyrie appartengono ad un ordine che non ha niente a che fare con espressioni equivoche dell'”esplodere” e dell'”essere oppressi”, poiché lo spazio, per la tradizione di cui è portatore, impone quella “moderazione” (s. Agostino) che si addice in presenza di Dio. Tutto questo costituisce la forma. E in liturgia la forma è un problema di fondo [6], poiché il “gioco del linguaggio” rituale – il sacramentum – è di ordine “-urgico” (è un linguaggio-azione, come attesta la sua radice greca “érgon”) e non di ordine “-logico” (come sono i discorsi di tipo scientifico); in altri termini, esso è di ordine pragmatico più ancora che di ordine semantico.
Evidentemente, ciò che costituisce la ricchezza dello spazio liturgico finisce per costituirne anche la sua fragilità. Il godimento estetico che esso permette e la routine rituale che in esso si svolge rischiano costantemente di smussare la lama affilata del vangelo, di soffocarne la novità e di mascherarne le esigenze etiche. Pertanto ha continuamente bisogno di essere evangelizzato. Trovare il giusto equilibrio fra questa evangelizzazione e il rispetto che la simbolica dello spazio liturgico impone non è certo una cosa facile. Esso dipende dalla diversità delle tradizioni delle chiese cristiane, dal tipo di assemblea celebrante come pure dal “carisma” dei diversi ministri. In ogni caso, non si può sacrificare né l’una né l’altra realtà.
Uno spazio transizionale
Alla luce degli studi compiuti da D.W. Winnicott, c’è ancora un ultimo aspetto da considerare in riferimento allo spazio liturgico [7]. Lo psicanalista inglese ha sviluppato le sue considerazioni partendo dall'”oggetto transizionale” (un orso di peluche, l’angolo di una coperta, una parola, una melodia, ecc.) che i bambini usano, per esempio, per addormentarsi. Questo oggetto esercita una funzione sostitutiva della madre e di “difesa contro l’angoscia” (p. 11 [trad. it. cit., 28]) causata dalla sua assenza. Winnicott sottolinea pure che, oltre questa negoziazione di rapporto con la madre assente, qui è in gioco la mediazione di rapporto con se stessi e con la realtà. L’oggetto permette al bambino di effettuare «la transizione […] da uno stato di essere fuso con la madre ad uno stato di essere in rapporto con la madre come qualcosa di esterno e separato» (p. 26 [trad. it. cit., 43]): transizione dal fantasma (al quale il bambino si attiene durante i primi mesi di vita, poiché in tale fase non si differenzia dal seno materno [8]) alla realtà. Questo passaggio richiede che siano «separate e, tuttavia, correlate la realtà interna e la realtà esterna» (p. 9 [trad. it. cit., 26s.]). Esso è «un compito mai completato» per l’essere umano (p. 24 [trad. it. cit., 41]). Winnicott si impegna, dunque, a dimostrare come l’oggetto transizionale del bambino costituisce il punto di partenza di un processo per cui «per tutta la vita viene mantenuta una sperimentazione interna che caratterizza le arti, la religione, il vivere immaginativo e il lavoro scientifico creativo» (p. 25 [trad. it. cit., 43]): tutti i fenomeni culturali nel loro insieme devono infatti essere considerati come un processo di “fenomeni transizionali”. Fra l’area psichica interna e l’area della realtà esterna esiste, dunque, una «terza area […] dove si situa l’esperienza culturale, ovvero il gioco creativo», che l’autore chiama “spazio potenziale”. È a questo livello che, attraverso il gioco, la creazione artistica o la ritualità religiosa, viene mediato il rapporto con il reale (pp. 148-149 [trad. it. cit., 165ss.]).
Non ha forse lo spazio liturgico qualcosa a che fare con questo spazio potenziale, come ritiene J.Y. Hameline, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con la memoria «che attraverso la mediazione delle forme, degli oggetti, delle disposizioni rituali, ha il potere di raggiungere in noi la memoria nascosta di eventi primigenii, legati a transizioni fondanti» [9]? Oscillando fra due derive, quella estetica della semplice decorazione o del “bell’oggetto”, che stimola l’immaginario, e quella funzionale dell’utilità e della comodità che, al contrario, inibisce l’immaginario a favore di uno pseudo-realismo, lo spazio liturgico è «direttamente legato ad una transizionalità che si raffronta all’origine e alla fine, cioè con tutto ciò che nella vita è articolato secondo il movimento della separazione, nella sua triplice direzione che va dal soggetto verso se stesso, verso i suoi simili e verso la figura del Dio nascosto» [10]. Fra queste due derive, che trasformano il “mantenimento” (holding) in “manipolazione” (handling), lo spazio liturgico è essenzialmente contrassegnato dalla precarietà, che si inserisce nel solco dello spazio potenziale. Questo spazio che si viene a creare fra il bambino e colei che per lui rappresenta la “disponibilità affettiva”, ovvero l'”amore incondizionato” [11] rischia in modo permanente di essere colmato troppo frettolosamente, in quanto l’essere umano, fin dall’origine, ha orrore del vuoto. Le diverse forme di lutto esigite dalla separazione, e l’angoscia che tale separazione suscita, generano nell’essere umano quello stato depressivo che lo spinge inesorabilmente a colmare il vuoto provocato dall’assenza in mille modi. Il che può avvenire attraverso i discorsi rassicuranti sulla “presenza” o attravrso l’orgoglioso attaccamento al rituale giustificandolo come “rispetto della tradizione” o “senso del sacro”. «Lo spazio del santuario è, come ogni altro luogo transizionale, sotto la minaccia permanente di questa forma di negazione del lutto, quale dispositivo maniacale di difesa»; esso è pure «particolarmente vulnerabile al ritorno degli oggetti persecutori» [12].
La precarietà dello spazio liturgico, come si deduce dall’etimologia stessa del termine, ha d’altra parte un particolare legame con l’uomo che prega (precarius). Infatti, come dimostra la preghiera liturgica della chiesa nelle sue diverse forme, che vanno dalla domanda (postulatio) alla richiesta generale dell’aiuto di Dio (supplicatio), oppure alla sottile insinuatio; dalla “gratiarum actio” alla rude “obsecratio” o “contestatio per sacra” [13], che cos’è la preghiera se non un “gioco”? Un gioco di negoziazione della giusta distanza fra l’essere umano e Dio, fra presenza e assenza. Un gioco che permette al soggetto credente di intrattenere la relazione con Dio, pur mantenendo la separazione da lui. Si tratta di un compito in verità difficile in quanto presuppone un fondamentale distacco da sé e da quel “Dio” al quale il mio io si aggrappa per uscirne inevitabilmente ferito, come Giacobbe nella sua lotta con Dio presso il torrente dello Iabbok (Gn 32,23-33). Ma questa ferita di narcisismo è feconda perché è il frutto di una prova di forza con un Dio che “resiste”. Così lo spazio liturgico, proprio per la sua precarietà in quanto spazio transizionale, appare come eminentemente congruo alla precarietà della preghiera, là dove si “gioca” la prova del rapporto con Dio, un Dio che, sollecitando i suoi figli ad andare verso di lui con tutta l’umanità della loro vita, accetta il rischio di vedersi manipolato come presenza immediata. Un rischio che egli accetta in quanto offre un’opportunità: quella di insegnare agli uomini, a loro spese, ad assumere la sua “assenza” e a convertire, pertanto, i loro desideri.
La teologia sacramentaria alla luce di questa prospettiva
Da quanto si è detto fin qui, emergono delle prospettive che influenzano non soltanto il modo di comprendere e vivere la liturgia, ma anche la stessa teologia sacramentaria. Infatti se i sacramenti, come dice s. Tommaso d’Aquino, sono “in genere signi” cioè se il loro modo di essere efficaci è legato alla funzione stessa di significare, come è possibile enunciare a questo riguardo qualcosa di pertinente senza tenere conto prioritariamente dell’azione liturgica? Le considerazioni che sono state presentate qui dovrebbero stimolare gli esperti di sacramentaria ad elaborare un discorso teologico che, affrontando il sacramentum in tutte le sue dimensioni, in particolare e soprattutto nelle sue componenti simboliche preconsce e preconcettuali, sia meno “anestetico” di quanto non lo sia tuttora. [14]
Abbiamo visto come lo spazio liturgico parla. Esso parla in quanto spazio cristiano attraverso gli oggetti e gli attori che, interagendo, lo compongono, manifestando così metaforicamente il mistero di Cristo e metonimicamente la comunione ecclesiale nel tempo e nello spazio. Parla come “matrice” iniziatica, attraverso la quale ciascuno raggiunge la sua identità di cristiano; parla come sito illocutorio che, per la sua pregnanza simbolica, in-forma sia l’emissione che la ricezione del messaggio cristiano che è trasmesso; parla come spazio transizionale, che permette di negoziare la giusta distanza con il Dio nascosto.
Orbene, questo spazio appartiene in modo eminente al sacramentum. Certamente è legittimo e necessario concentrare l’attenzione, ad un certo momento, su ciò che costituisce la substantia sacramenti – ciò che nel linguaggio della scolastica si chiama “materia” e “forma” – e fornire, con la dovuta precisione concettuale, i fondamenti teologici ed anche canonici, oltre i quali l’identità stessa del sacramento sarebbe a rischio. Ma la sacramentaria non potrebbe fermarsi a questo livello se non con il pericolo di andare alla deriva verso il giuridismo angusto e la speculazione astratta. Come ogni altro ramo della teologia essa deve negoziare costantemente fra il sapere concettuale (senza il quale essa non sarebbe più teologia, dunque discorso organico – “scienza”, come direbbero gli scolastici) e il non-sapere simbolico (senza il quale essa non rispetterebbe più il mistero di Dio). A partire dalla pratica della chiesa celebrante, essa ha a che fare con la molteplicità dei simboli che la liturgia offre ai cinque sensi. La sacramentaria, mettendo in luce l’intenzionalità dei simboli e ordinandoli secondo la logica teologica che sottende la celebrazione liturgica, ha il compito di ricondurre questi simboli al concetto. Tuttavia, sebbene con il rischio di lasciarsi affascinare dai sette riti che “causano ciò che significano” e di rinchiudersi pertanto nella problematica, certamente utile ma troppo angusta, della “differenza specifica” dei sette sacramenti rispetto agli altri atti di culto, essa non deve mai scordare di ricondurre sempre il concetto alla sua sorgente viva: i simboli posti in atto dall’azione liturgica.
Abbiamo anche detto che questi simboli parlano ai partecipanti a “fior di pelle”. Senza dubbio è necessario che essi vengano ripresi all’interno di un discorso specificatamente cristiano, che a sua volta viene convalidato dall’esperienza viva. All’interno di questo discorso, però, essi non sono tanto degli elementi da interpretare quanto piuttosto essi stessi costituiscono l'”operatore immanente” dell’interpretazione. Lo spazio al quale essi danno vita in quanto “sito illocutorio” parla transitivamente ai partecipanti e li situa in rapporto alla chiesa e a Cristo al di qua dei contenuti dei discorsi proferiti (preghiere, letture, canti, ecc.). Pertanto, se l’efficacia oggettiva dei sacramenti – ciò che la tradizione teologica chiama con il bel termine di “grazia” – non dipende dalle disposizioni del ministro e neppure da quelle di chi li riceve, la loro fecondità soggettiva invece è legata a queste disposizioni: «Accipit quisque secundum fidem suam» [ciascuno riceve secondo la propria fede]; così scriveva s. Agostino a proposito del battesimo. In altre parole, se il dono di Dio nei sacramenti dipende dalla sola liberalità di Dio, la ricezione di questo dono, in quanto tale, cioè come grazia (e non come qualcosa che dipenderebbe dal calcolo) è in misura del contro-dono da parte del soggetto – un po’ come l’accoglienza di un regalo come regalo o dono gratuito, e non come oggetto-valore, dipende dal contro-dono di colui che lo riceve: come minimo un grazie, un sorriso, un’espressione di riconoscenza. Se, al fine di pensare teologicamente i sacramenti, si intende uscire dai casi-limite – senz’altro utili e preziosi per affinare la teoria, come lo sono i casi patologici in psicoanalisi – e ci si vuol porre, come è doveroso, nel contesto dei casi “normali” della vita cristiana, una teoria sacramentaria, che non integrasse le disposizioni del soggetto per accentuare unicamente la gratuità del dono di Dio, verrebbe a mancare del suo oggetto proprio. Infatti, il suo oggetto sono le due realtà considerate insieme: la gratuità di un dono che non viene misurato, da parte di Dio, in base ai meriti o demeriti dell’uomo e la fecondità spirituale di questo dono, la quale dipende dalle disposizioni del soggetto.
Senza essere proporzionali al clima della celebrazione, queste diposizioni di fede e d’amore sono da esso favorite o ostacolate. Per questo il “sito” liturgico non potrebbe affatto essere considerato come una realtà estranea alla teologia sacramentaria. Esso ne è invece parte intrinseca, proprio come fa parte della teologia della celebrazione eucaristica, ad esempio, il particolare “colore” che è specifico di questo o di quel tempo liturgico. La celebra formula di s. Agostino: «Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum» [se a questo elemento si unisce la parola, si forma il sacramento (In Io. Evang. 80,3)] è di grande aiuto per comprendere questa realtà. Il “verbum” in questione, che “diventa sacramentum”, non può essere strettamente limitato alla semplice parola sacramentale; esso designa, a monte, non soltanto il Cristo-Verbo, ma anche il modo concreto attraverso il quale egli si fa conoscere, in particolare attraverso la liturgia della Parola o gli altri elementi che fanno sì che una domenica di quaresima non abbia lo stesso “colore” di una domenica del tempo di Pasqua o del tempo ordinario. Il “verbo” che si cristallizza nella parola sacramentale (livello 3) è sempre lo stesso Cristo-Verbo (livello 1), ma con quelle modalità particolari attraverso le quali egli si presenta secondo il “sacramentum” del tempo liturgico (livello 2). Mandare in corto circuito questo secondo livello con il pretesto che l’eucaristia è sempre la “stessa” significa misconoscere la funzione della mediazione liturgica. Con questa mentalità si potrebbe ridurre la “celebrazione” alla sola “consacrazione”!
Prendere sul serio questo secondo livello, cioè il concreto sacramentum che costituisce la celebrazione liturgica, come parte integrante della sacramentaria, è un traguardo che chiede ancora oggi di essere verificato. Le riflessioni fin qui esposte non avevano altro scopo se non quello di sottolineare l’importanza di questo compito con tutto ciò che comporta di ulteriore riflessione sulla corporeità e sulla mediazione dei sensi. La nozione di “spazio liturgico”, come è stata qui prospettata, ci sembra manifestare bene l’interesse e il peso teologici di un’autentica “antropologia sacramentale”. E proprio ciò che nel 1974 il padre Chenu proponeva agli studiosi di sacramentaria: «Antropologia sacramentale: questo termine assume tutta la sua densità non come illustrazione di una realtà sacramentale già conosciuta in antecedenza, ma come un aspetto co-essenziale del sacramento. Noi non possiamo comprendere il sacramento se non nella sua consustanzialità con l’uomo. I due termini “antropologia” e “sacramentale” sono indissociabili non soltanto sul piano del metodo – il che sarebbe già un risultato prezioso – ma sul piano costitutivo del sacramento stesso» [15].
Questo invito è stato in parte già accolto. Tuttavia, è certo che si può andare molto più lontano su questa strada: la filosofia (in particolare quella del linguaggio) come pure le diverse discipline nell’ambito delle scienze umane (ritologia, linguistica, psicologia, psicoanalisi, sociologia, storia, ecc.) aprono nuove vie al pensiero e forniscono dei metodi e degli strumenti che chiedono ancora di essere esplorati e utilizzati. Questa impresa è senza dubbio difficile, ma ne vale la pena perché si tratta di permettere ai nostro contemporanei di comprendere e di vivere “nella propria lingua” (At 2,11) la liturgia della chiesa.
NOTE
1 E. ORTIGUES, Le discours et le symbole, Aubier-Montaigne, Paris 1962, 221.
2 Cf. l’articolo di I. Renaud-Chamska in questo numero di Concilium; ID., Les actes de langage dans la prière, in La Maison-Dieu 196 (1993/4) 87-110.
3 J.L.. AUSTIN, Quand dire, c’est faire, Seuil, Paris 1970 [trad. it., Come fare cose con le parole, Marietti, Genova 1987].
4 P. RICOEUR, Poétique et symbolique, in Initiation à la pratique de la thélogie I, Cerf 1982, 43 [trad. it., Poetica e simbolica, in B. LAUREI – F. REFOULÉ • (edd.), Iniziazione alla pratica della teologia I, Queriniana, Brescia 1986, 41s.].
5 J. LACAN, Ecrits, Seuil 1966, 276 [trad. it., Scritti, Einaudi, Torino 1974].
6 Tra l’altro, questo spiega perché venendo a mancare la “forma” sacramentale (nel senso teologico del termine) viene a mancare anche il fondamento stesso del sacramento, che pertanto sarà invalido.
7 D.W. WINNICOTT, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Gallimard 1975 [trad. it., Gioco e realtà, Armando