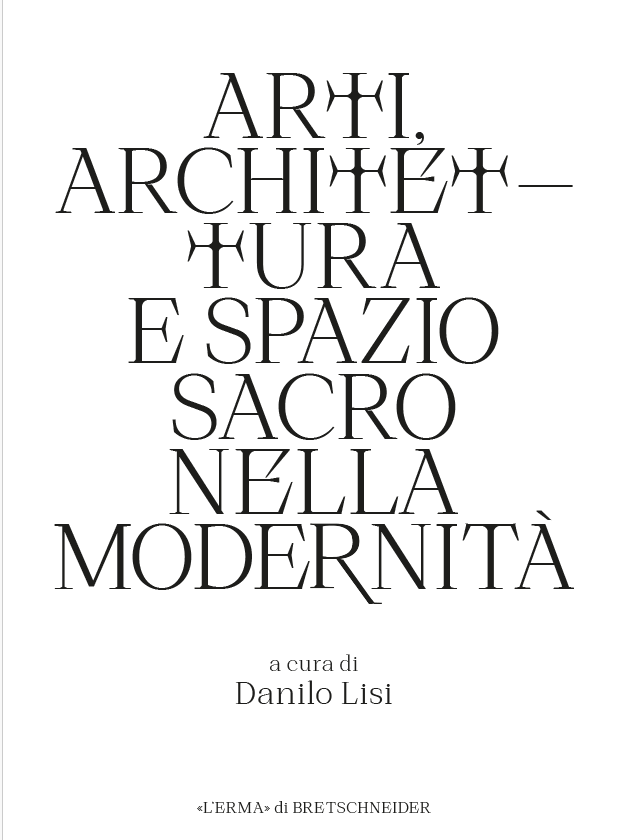Un’ondata di ottimismo. Un’aria nuova nel rapporto tra arte, architettura e Chiesa che tanto è stato travagliato in questa nostra epoca desacralizzata: la si respira sfogliando il volume, curato da Danilo Lisi, Arti, architettura e spazio sacro nella modernità (L’Erma, pagine 226). Come scrive nell’introduzione S.E.R. Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede: “L’incontro tra l’arte e il sacro è un dialogo antico quanto l’umanità stessa. Tuttavia, negli ultimi decenni, il confronto tra la tradizione e l’innovazione, tra le radici spirituali e le espressioni contemporanee, ha assunto una complessità nuova e spesso provocatoria. Questo ha portato alla creazione di edifici che non sono solo «contenitori» per il culto, ma vere e proprie espressioni visive della fede vissuta, in grado di dialogare con l’ambiente circostante e con le aspirazioni spirituali dell’uomo contemporaneo”.
Lo presentiamo con una breve intervista al curatore del volume e quindi con la riproduzione del suo intervento che ne riassume i contenuti.
Danilo Lisi: l’essenzialità della forma nel progetto delle chiese
Negli ultimi decenni già molto è stato scritto su tematiche attinenti all’architettura per il culto: come mai hai sentito la necessità di esplorare ulteriormente l’argomento e che particolarità ha quest’opera da te curata?
Sinceramente non mi sembra ci siano molte pubblicazioni in proposito. Mi riferisco al tema del rapporto del rapporto tra Arti e Architettura: già un paio di anni fa lo affrontai con riferimento all’ornato liturgico, e nelle ricerche che svolsi per preparalo trovai ben poco materiale.
Questo libro raccoglie una serie di testimonianze di alto profilo, svolte da esperti nelle diverse discipline che interessano il sacro: dalla liturgia all’iconografia, alla scultura, all’architettura. Ciò è ben evidenziato sin dalla prefazione del Cardinal José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero della Cultura e l’Educazione della Santa Sede: non il solito scritto di circostanza ma una riflessione accurata e densa, che si sofferma in particolare nel descrivere le opere minimaliste di Alvaro Siza e Tadao Ando in quanto espressioni dell’essenzialità degli aspetti rituali.
Voglio poi segnalare la raffinatezza dell’impaginato e della grafica del volume, che reca foto inedite ed è stampato in un formato importante dalla prestigiosa casa editrice L’ERMA di Bretschneider, specializzata in libri di arte.
L’architettura stessa delle chiese, la loro forma, spesso così variegata nell’epoca contemporanea, si rivela come espressione di ricerche artistiche. Ma questa proliferazione formale a volte genera sconcerto. Come risolvere tale problematica ai nostri giorni?
Io ho un’idea ben precisa sull’argomento, ma credo minoritaria e non necessariamente ben vista da chi dà le carte… Mi sembra che tale idea sia ben riassunta dal professor Franco Purini, che nella postfazione al libro scrive: “La Chiesa dovrebbe, a mio avviso, ritrovare alcune forme congruenti da interpretare volta per volta, ma non modificarle in modo sostanziale. Solo la ‘ripetizione ideale’ di uno spazio dalla tipologia precisa potrebbe trasmettere, a chi assiste al rito, la continuità architettonica della chiesa, che così sarebbe l’espressione di una ‘comunità unitaria’…”
Tali tematiche nel periodo post Concilio sono segnate da vari travagli. Ci si trova oggi in una fase nuova, magari più matura?
In particolare nella seconda parte del libro, intitolata “Uno sguardo a 60 anni dal Concilio”, vengono riportate alcune esperienze significative, come quella della ricostruzione della chiesa ortodossa di Saint Nicholas a Ground Zero, a New York, distrutta nel 2001 a seguito del crollo delle Torri Gemelle. Lì Santiago Calatrava riprende il concetto di “opera totale”, che già mise in pratica nel recupero della Cappella San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte in Napoli. Lia Pagliarani, profonda studiosa dell’opera del Maestro valenziano, illustra la genesi di questo progetto, in cui si evince l’intento di assegnare egual valore all’architettura e all’apparato iconografico e scultoreo.
Ecco, mi sembra che, in generale, su questo tema ci sia ancora molto da fare, sia da parte della committenza, sia da parte di noi professionisti.
Il contenuto del volume.
Estratto dal testo di Danilo Lisi
“Ripensare lo spazio cultuale: tra tradizione e modernità”
[….]
Il volume è stato pensato in due parti: nella prima, dal titolo “Il sacro nelle arti del Novecento” si analizzano alcune significative opere architettoniche, iconografiche e scultoree di grandi Maestri del Novecento. Nella seconda parte, “Uno sguardo a 60 Anni dal Concilio”, vengono riportate opere, progetti e nuove idee, compresa l’opera di Santiago Calatrava, appena ultimata, della chiesa ortodossa di St. Nicholas nel New World Trade Center, in New York.
Più in particolare, dopo la preziosa testimonianza del Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, e la presentazione della Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, professoressa Tiziana D’Acchille e del Presidente, avvocato Mario Rampini, segue lo scritto di don Luca Franceschini, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiali e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo una sintetica cronistoria relativa alla costruzione di nuove chiese in Italia, don Luca approfondisce le ragioni del passaggio dai progetti pilota ai Concorsi Diocesani diffusi, con le coordinate e gli spazi tematici dell’attuale logica programmatoria e conseguenti finalità, sia da un punto di vista pastorale, liturgico, estetico-formale, partecipativo, sia nell’ottica delle nuove realtà urbane, in particolare delle periferie. Franceschini lascia aperto, in chiusura, la possibilità di percorrere, in futuro, altre modalità da seguire, anche quelle dell’incarico diretto.
Apre la prima parte “Il sacro nelle arti del Novecento” Elena Pontiggia che mette in evidenza come la spesso deludente arte sacra contemporanea ha nei suoi esiti migliori il pregio dell’originalità e delle invenzioni iconografiche grazie alla sua libertà espressiva e, anche, alla frequente mancanza di una committenza. L’autrice ne evidenzia alcuni esempi (Arturo Martini, Carrà, Birolli, Manzù, Carpi, Sassu, Dalì) distinguendo la vera originalità dalla gratuita eccentricità.
Bianca Pedace ci descrive la sacralità della luce nella pittura di Mark Rothko, in particolare il suo ultimo impegno per la cappella interconfessionale a Houston, commissionata dai coniugi de Menil, nella quale egli realizza quattordici dipinti. L’opera verrà inaugurata nel 1971 dopo la morte dell’artista.
Maria Antonietta Crippa affronta l’attuale tema, in architettura, del binomio ornamento-struttura/ tettonica. Esso infatti risulta di primaria importanza nelle chiese di contesto cristiano, nei loro arredi e nelle loro suppellettili liturgiche, rispondenti a esigenze comunitarie e coinvolte in processi comunicativi profondi. Il saggio ne esemplifica la rilevanza in otto casi, inseriti in confronti binari, facendoli emergere come segni sorprendenti della festa della fede.
A concludere la prima parte Tiziana Proietti, che approfondisce un tema fondamentale per un architetto, quale la proporzione, analizzando l’opera del monaco benedettino Hans van der Laan. Se negli anni ’50 il concetto di proporzione fu messo in discussione, apparendo distante dai temi della contemporaneità, la Proietti ci illustra come Hans van der Laan propose una nuova prospettiva, vedendo la proporzione oltre il suo valore estetico, simbolico o matematico. Sviluppò così la teoria proporzionale del Numero Plastico al fine di ordinare l’infinità della natura in dimensioni e proporzioni secondo le modalità con cui l’essere umano le percepisce. Nel saggio la Proietti esplora alcuni aspetti di questa teoria utili a riconsiderare le modalità con cui la proporzione può tornare a essere uno degli strumenti fondamentali del mestiere dell’architetto.
La seconda parte del libro “Uno sguardo a 60 anni dal Concilio” è aperta da Andrea Dall’Asta con una domanda: “Divorzio tra arte e fede?”. Il suo pensiero è sicuramente critico verso la moltitudine di chiese che sono state costruite negli ultimi decenni, sia da un punto di vista architettonico sia artistico. A poco sono serviti gli appelli di Paolo VI nel 1964 e a seguire quelli di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e non ultimo quello di Papa Francesco. Al di là di alcuni interventi degni di nota, come le splendide vetrate di Gerhard Richter nella Cattedrale di Colonia, le sperimentazioni di Bill Viola, o le opere di Claudio Parmiggiani, Ettore Spalletti e pochi altri, Dall’Asta sostiene che manca una seria e positiva riflessione sull’arte sacra. Nonostante questa nuda e amara constatazione, chiude lo scritto con uno speranzoso: “Abbiamo fiducia nel futuro!”.
Manlio Sodi si pone interrogativi, già dal titolo, che sollecitano risposte per dare forma alle espressioni nel grande contesto dei linguaggi dell’arte, e che riguardano il dialogo tra bellezza e teologia nella modernità. Suscitare emozione è uno degli obiettivi dei linguaggi liturgici; non l’unico, ma non certo il meno importante. Sodi fa riferimento all’uso delle immagini, dei colori, della luce naturale, radente o zenitale, che pervade l’assemblea nelle varie ore della giornata. L’emozione è un motus dell’animo, dello spirito, che suscitata da elementi visivi e acustici ha la capacità di volgere lo spirito a una partecipazione più intensa alla celebrazione liturgica.
Mariano Apa documenta, anche grazie alla propria appassionata dedizione di storico dell’arte alla terra e alla cultura umbra, alcune significative esperienze di arte sacra, quale arte di un territorio, ma non in quanto ideologia di una geografia, bensì quale stagione di ricerche di singoli artisti all’interno e fuori in dialogo con il Magistero della Chiesa, prima e dopo il Concilio Vaticano II.
Mario Pisani illustra la poetica alla base delle architetture sacre realizzate da Paolo Portoghesi a partire dalla chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, nel 1968, fino alla recente Concatterdrale di Lamezia Terme. Descrive come Portoghesi, nelle otto chiese realizzate, oltre a numerose cappelle, ha sempre cercato di utilizzare il linguaggio dei simboli per rendere visibile l’invisibile e, nello stesso tempo, far scaturire il nuovo dall’antico. Pisani illustra anche la Moschea di Strasburgo e quella di Roma, a Monte Antenne, che lo vide, come giovane cronista e critico, documentare l’andamento dei lavori intervistando in cantiere anche l’allora sindaco Giulio Carlo Argan.
Stefano Mavilio, prima di passare a illustrare le chiese da me costruite negli anni ed esposte al Convegno del 30 novembre / 1 dicembre 2023 presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia, approfondisce il linguaggio dei simboli e gli aspetti numerologici e geometrici che caratterizzano la costruzione di un luogo sacro. Tra gli altri chiama in causa Mircea Eliade, che riteneva tale operazione una cosmogonia, cioè la ripetizione rituale dell’atto creatore iniziale.
Tino Grisi esplora, illustrando due suoi progetti, il contrasto tra design e contesto architettonico liturgico. Nel primo progetto, per l’adeguamento liturgico della cattedrale di Santa Maria Assunta in Asti, in cui l’Arca della Comunità diventa simbolo potente della Chiesa come luogo di incontro tra Dio e l’Umanità. Nel secondo progetto, per la nuova chiesa Regina Pacis a Giavera del Montello (Treviso), Grisi mette in luce la forte connessione tra natura e architettura religiosa. L’edificio, di forma circolare, rappresenta un luogo di raccoglimento che unisce la comunità, aperto verso l’esterno e il divino. La relazione tra spazio, liturgia e natura diventa così centrale, trasformando la chiesa in un giardino spirituale che invita all’introspezione e alla contemplazione.
Rosalia Pagliarani documenta la chiesa greco- ortodossa di St. Nicholas, New World Trade Center, in New York, recentemente ultimata e consacrata, in luogo della precedente dell’inizio del Novecento, distrutta dal crollo della torre meridionale l’11 settembre 2001. Qui l’architetto Santiago Calatrava ha continuato quella ricerca, già iniziata nel recupero della Cappella San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, in Napoli, alla riscoperta dell’arte totale: una fusione che va dall’architettura all’apparato iconografico e scultoreo, fino ai paramenti sacri.
Nella postfazione Franco Purini sostiene che se realizzare un qualsiasi edificio è di per sé un’azione sacra, lo è ancor di più quando si tratta di erigere una chiesa, una moschea, una sinagoga, un tempio buddista. Per costruire una chiesa ai giorni nostri, oltre al delicato rapporto con la città contemporanea e in particolare con le sue degradate periferie, bisogna affrontare diversi aspetti: liturgici e artistici, nonché quelli legati alla tipologia, allo spazio e alla luce. Proprio su questi ultimi due punti Purini si sofferma: descrive sia la sua definizione di luce, quella che ha costruito nel corso degli anni, sia il suo concetto di spazio, sostenendo che “solo la ripetizione ideale di uno spazio dalla tipologia precisa potrebbe trasmettere, a chi assiste al rito, la continuità architettonica della chiesa, che così sarebbe l’espressione di una comunità unitaria”.